 |
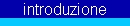 |
 |
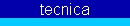 |
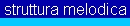 |
 |
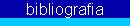 |
 |
|
CONCERTI
E STRUTTURA MUSICALE
CARATTERISTICHE DEI CONCERTI I concerti di campane composti secondo l'ANTICA ARTE CAMPANARIA BOLOGNESE sono essenzialmente uno strumento musicale in grado di emettere quattro o più suoni articolati secondo la caratteristica struttura musicale e suonato da più persone simultaneamente. Pur esistendo antichi concerti composti da 3 campane, la base di ogni concerto qui considerata per la struttura musicale è comunque di 4 campane, anche se alcuni comprendono 5 o, più raramente, 6 campane. I
concerti di 4 campane sono identificati in base alla loro
INTONAZIONE. Posto che non si realizza in essi la
possibilità
di una vera e propria scala musicale, essi sono definiti in funzione
dell’INTERVALLO che separa i vari suoni, collocati comunque
idealmente su di una scala
diatonica.
Si prende in considerazione la campana di suono più grave,
la
GROSSA e si esaminano i gradi degli intervalli che separano il suo
suono da quello delle altre, si avranno così tre Intonazioni
dei concerti definiti QUARTI (supposta per comodità di
esposizione come DO la nota più grave):
|
QUARTI
|
|
MAGGIORE |
|
MINORE |
|
SESTA |
|
|
GROSSA |
DO |
fondamentale |
DO |
fondamentale |
DO |
fondamentale |
|
MEZZANA |
RE |
2a maggiore |
MI b |
3a minore |
FA |
4a giusta |
|
MEZZANELLA |
MI |
3a maggiore |
FA |
4a giusta |
SOL |
5a giusta |
|
PICCOLA |
SOL |
5a giusta |
SOL |
5a giusta |
LA |
6a maggiore |
|
I concerti di 5 campane definiti QUINTI propriamente detti sono sviluppati sulla base di un concerto di Quarto Maggiore al quale viene aggiunta una quinta campana - nominata QUARTA, che occupa il quarto grado della scala: |
QUINTO MAGGIORE
| Così i concerti (rarissimi) di sei campane definiti SESTI propriamente detti aggiungono al Quinto una sesta campana, nominata SESTA che occupa il sesto grado della scala: |
-
GROSSA
DO
fondamentale MEZZANA
RE
2a maggiore
MEZZANELLA
MI
3a maggiore
QUARTA
FA
4a giusta
PICCOLA
SOL
5a giusta
SESTA
LA
6a maggiore
|
Più frequentemente esistono concerti di 5 o 6 campane dove sono presenti due (eccezionalmente tre) concerti distinti, tacendo una campana; ad esempio Quarto Maggiore e Minore o Quarto Maggiore e Sesta, che prende il nome anche di OTTAVA, essendo la Piccola del concerto maggiore un’ottava più alta della Grossa del concerto di Sesta. Una nota vada al concerto di quarto che comprende tra il suono più grave ed il più acuto l'intervallo di quarta eccedente, il tritono, “diabolus in musica”, cioè tre toni interi (Es.: Chiesa Parrocchiale dei Ss. Vitale e Agricola, BO). STRUTTURA DEL SUONO A DOPPIO Essendo solo quattro i suoni diversi che possono essere generati da un concerto di campane equipaggiate alla bolognese (il suono con 5 e 6 campane viene compreso in casi particolari, comunque segue generalmente la struttura base, che è con 4 campane), non realizzandosi così una scala musicale ancorché incompleta, si è sviluppato e consolidato un sistema di suono basato sulla struttura di matrici matematiche. Il campanaro quindi non “impara” i brani a memoria ma solo la base della struttura, cioè la matrice, elaborandola e sviluppandola mentalmente mentre sta eseguendo i brani stabiliti, rigorosamente codificati in repertori ormai classici ed immutabili; non viene concessa cioè agli esecutori nessuna variazione o interpretazione personale. Se all’apparenza quattro soli suoni sembrano limitativi in realtà le possibilità di combinazioni, disposizioni, permutazioni e sostituzioni sono pressoché infinite. Da ciò si intuisce come sia mirabilmente complicato il suonare le campane alla bolognese, considerando anche la non facile, faticosa e spettacolare tecnica. Il suono delle campane alla bolognese basa quindi la propria struttura sull’elemento semplice definito MEZZA, corrispondente alla successione dei rintocchi che ognuna delle quattro campane emette per una volta passando dalla posizione di MEZZOLO a quella di BOCCA o viceversa, compiendo una rotazione di 360°. Le campane base sono quattro, così denominate e descritte, nella comunicazione orale e nella trascrizione musicale dei brani, partendo da quella di peso maggiore, in ordine decrescente: |
|
Nome campana |
in un brano espresso a voce |
in un brano scritto |
|
GROSSA |
DON |
4 |
|
MEZZANA |
DAN |
3 |
|
MEZZANELLA |
DEN |
2 |
|
PICCOLA |
DIN |
1 |
|
Considerando quindi un rintocco per campana, essendo dunque esse 4, Le Mezze diverse possibili derivano da una permutazione e sono 4! = 24 (fattoriale di 4) e vengono – generalmente – raggruppate in combinazioni definite in base a una campana che suoni lei stessa sempre per ultima; avremo così 4 gruppi di 6 Mezze le quali ora assumono ognuna proprio nome identificativo, detti PEZZI, qui indicati, per comodità espositiva, in ordine numerale crescente. A seconda della campana che suoni per ultima i Pezzi possono essere di GROSSA, di MEZZANA, di MEZZANELLA e di PICCOLA. Sono i più usati i Pezzi dove la Grossa suona sempre per ultima, le Mezze sono così 3! = 6 (fattoriale di 3);: 1234
= organo Estrapolando dai 24 Pezzi quelli dove la Grossa suona sempre per terza si ottengono, ad esempio, i Pezzi MODENESI, altra combinazione caratteristica. 1243 = organo modenese 1342 = quarto modenese 2143 = deldin o dendin modenese 2341 = deldan o dendan modenese 3142 = San Pietro o dondin o dandin modenese 3241 = Certosa o rovescio o donden o danden modenese I Pezzi – nella esecuzione di un brano – possono essere eseguiti anche MATTI: alcune (e anche tutte) le campane si scambiano il proprio turno di suono assumendo il ruolo delle altre. Ad esempio nei pezzi eseguiti di Campanino Matto tutte le campane si scambiano il turno di suono: la Piccola avrà il ruolo della Grossa; la Mezzanella quello della Piccola; la Mezzana quello della Mezzanella e la Grossa quello della Mezzana. Stabilite
ed esaurite (almeno per quel che riguarda la base stutturale dei
brani che partecipano al repertorio classico del suono a doppio e
tirata bassa) le combinazioni delle Mezze – assurte ora ora
alla dignità individuale di Pezzi – si esaminano
le
possibilità di disposizione e l'applicazione di esse.
Si
ricordi che nel gergo quotidiano il sostantivo usato e omologato per
i Pezzi è – generalmente – quello di
Mezze, intese
sempre (salvo ovviamente avvertimento ) di Grossa.
Le
possibilità di disposizione delle 6 Mezze, cioè i
Pezzi, sono teoricamente 6! = 720 (fattoriale di 6) ma nelle
esecuzioni, di fatto, se ne utilizzano principalmente 3 (tra quelle
dove le Grossa suoni per ultima e il primo Pezzo sia quarto),
le quali assumono nomi tipici:
|
|
Mezze in Scala |
Mezze in San Pietro |
Mezze in Certosa |
|
1324 quarto |
1324 quarto |
1324 quarto |
|
1234 organo |
3124 San Pietro |
3214 Certosa |
|
2134 deldin |
1234 organo |
2134 deldin |
|
2314 deldan |
2314 deldan |
1234 organo |
|
3124 San Pietro |
3214 Certosa |
2314 deldan |
|
3214 Certosa |
2134 deldin |
3124 San Pietro |
| Esistono altre 3 disposizioni, conosciute, ma pressoché inutilizzate; sono: |
|
Mezze in Taccotto nuovo |
Mezze in Taccotto vecchio |
Mezze in Marano |
|
1324 quarto |
1324 quarto |
1324 quarto |
|
2314 deldan |
2134 deldin |
3214 Certosa |
|
1234 organo |
3124 San Pietro |
3124 San Pietro |
|
3124 San Pietro |
2314 deldan |
2314 deldan |
|
2134 deldin |
1234 organo |
2134 deldin |
|
3214 Certosa |
3214 Certosa |
1234 organo |
Tutti i Pezzi e i brani possono essere eseguiti in ognuna di queste disposizioni. Riassumendo: le Mezze sono l'insieme generico dei singoli suoni di ogni campana; i Pezzi sono le Mezze identificate in combinazioni di suoni secondo criteri logici; le disposizioni in successione delle Mezze assumono nomi tipici. Ciò finora esposto costituisce l'impianto fondamentale sul quale si basa tutta la struttura compositiva del suono a doppio e titata bassa eseguito con tecnica alla bolognese. Particolare combinazioni generano altre disposizioni distinte dal genere descritto, sono per esempio, l'Annunziata (molto usata), giocata sulla Mezza deldin dei Pezzi Modenesi attraverso il progressivo slittamento posizionale delle campane e la Carità, una sorta di intreccio di Mezze di Grossa e Mezze Modenesi, generate dalle Mezze Quarto, Organo e deldan nei Pezzi Modenesi, ognuna seguita da una mezza creata dallo scambio simultaneo della prima campana con la seconda e della terza con la quarta, cioè barattate (o becche): |
-
l'Annunziata
la Carità
2143
1342
1432
3124
4321
1243
3214
2134
-
2341
-
321
|
COSTRUZIONE DEI BRANI I
brani sono costruiti su ogni Mezza (o più correttamente
sarebbe dire su
ogni Pezzo,
ma si mantiene questa definizione per adesione al lessico corrente),
la quale funge da capostipite e può generare altre
combinazioni di suoni, attraverso permutazioni e sostituzioni: alcune
campane tacciono e vengono perciò sostituite (combinazione con ripetizione) da una delle
altre per riformare l’ordine di 4 o più rintocchi
e
realizzare così una combinazione di suoni nuova ma
dipendente
da quella Mezza: ogni combinazione dipendente si chiama CAMPETTO.
L'esempio che segue illustra la generazione delle Dodici Vecchie, eseguite in Scala. (in neretto la Mezza capostipite) Campetto
di quarto Campetto
di organo Campetto
di deldin Campetto
di deldan Campetto
di San Pietro Campetto
di Certosa Così, aggiungendo ad ogni Mezza capostipite altre sostituzioni e permutazioni di campane, sempre rispettando il numero dei rintocchi in modo che al termine del brano le campane si trovino tutte nella posizione di Mezzolo, si generano altri brani, virtualmente di numero illimitato, ovviamente tutti eseguibili nelle varie disposizioni. |
Qui puoi scaricare una sinossi di vari brani (a ciap, trave e tirabasse) per concerti di 3, 4, 5 campane con citazione anche per 6 campane
